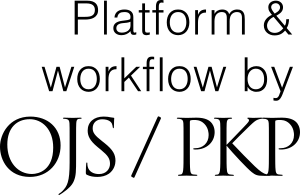LO HUMAN TERRAIN NELLE OPERAZIONI MILITARI
Abstract
Negli attuali scenari operativi la componente militare viene spesso impiegata in regioni culturalmente lontane da quelle di provenienza. Si tratta di aree dilaniate da conflitti feroci, in cui i contingenti sono chiamati a confrontarsi e a interagire con una moltitudine di attori che differiscono per etnia, religione, ideali politici, cultura, classe sociale: tutti aspetti sottesi al tessuto socio-culturale. Le diverse attività militari, dalla “stabilizzazione e ricostruzione” (S&R) alla contro-insurrezione, richiedono dunque da parte del personale impiegato la conoscenza quanto più approfondita e particolareggiata degli aspetti socio-culturali che caratterizzano un determinato ambiente operativo: tanto più le attività condotte sul campo saranno adattate al contesto locale, tanto più sarà favorito il successo dell’intera missione.
Modelli di intervento incentrati sul consenso della popolazione erano già stati teorizzati da T. E. Lawrence negli Anni ’20 e David Galula negli Anni ‘60; tuttavia la storia recente degli interventi in Iraq e in Afghanistan mostra il perdurare di un approccio marcatamente etnocentrico, in cui chi interviene opera ritenendo di sapere meglio degli “indigeni” cosa loro davvero serva in termini di governo, modelli sociali ed economici. Che sia per limiti conoscitivi, per la difficoltà di interagire con l’elemento locale, o per pura buona fede, i vertici delle missioni tendono ad appoggiarsi ad élite economiche e intellettuali di formazione cosmopolita maggiormente propense a sposare modelli di sviluppo occidentali, trascurando che una élite non è rappresentativa della popolazione. Inoltre la sola formazione professionale del personale militare, prevalentemente improntata all’approccio enemy centric (“distruggi il nemico, tutto il resto verrà di conseguenza”), non consente di proporre modelli di ricostruzione e sviluppo realmente rispondenti alle aspettative delle popolazioni locali, attraverso i quali si contribuirebbe a interrompere il circolo vizioso dell’insorgenza.
L’ambiente operativo è un ecosistema complesso, animato dal conflitto, in cui operano soggetti più o meno interconnessi che tendono a massimizzare i propri vantaggi in ottica collaborativa o competitiva (e distruttiva): le unità militari che raggiungono un teatro diventano parte integrante di questo ecosistema. Gli aspetti umani dell’ambiente operativo costituiscono un complesso insieme di elementi, fattori, processi e percezioni che interagiscono in una società immersa in livelli elevati di violenza, e influenzano la condotta delle operazioni. Alla luce del progressivo aumentare della popolazioni globale e della tendenza dei conflitti irregolari e asimmetrici a svilupparsi in aree densamente popolate, il classico approccio enemy centric non è dunque più premiale, e la popolazione diventa il centro di gravità, perché senza il suo supporto non può sussistere alcuna legittimazione dell’obiettivo primario di installare stati e governi di diritto localmente sostenibili, presupposto indispensabile di qualsivoglia intervento armato.
L’approccio population centric presuppone la conoscenza di come sia organizzata la società locale, da quali valori e credenze sia regolata, da chi promani l’autorità, chi gestisca il potere: implica cioè la profonda comprensione della dimensione sociale e culturale sottesa al teatro operativo. L’attuale processo di pianificazione militare prevede già la raccolta di informazioni sulle relazioni etniche, culturali, religiose, tribali, economiche e politiche: approcci come l’etnografia e l’intelligence culturale rendono visibili tutte quelle forme di organizzazione sociale autoctone che sono difficili da individuare con una lente occidentale perché costituite da modalità espressive che non ci sono familiari. Ma i costrutti culturali, rappresentati da credenze, valori, abitudini e comportamenti, con tutto l’intreccio di relazioni e significati che questi producono nei membri di una società, vanno interpretati affinché siano utili a definire strategie per interagire con le popolazioni locali. La conoscenza degli aspetti socio-culturali favorisce una migliore comprensione dei reali bisogni di un popolo, e aiuta a definire linee d’azione più efficaci e più aderenti alla realtà locale: se questa conoscenza non è, di per sé, suscettibile di indicare sempre e in maniera univoca le mosse degli avversari e dei cosiddetti non-combattenti, certamente può aiutare a comprendere le motivazioni alla base delle loro azioni, anche quando violente.
In tale quadro si colloca l’iniziativa statunitense dello Human Terrain System (HTS): un’applicazione multidisciplinare del metodo etnografico di ricerca sul campo in ambiente militare, adottato per pervenire ad una comprensione olistica del terreno, della popolazione, della cultura e della società presenti nell’area delle operazioni al fine di prendere decisioni consapevoli in situazioni di incertezza come quelle che caratterizzano i conflitti ibridi (ovvero quelli non puramente inter-statali). Il generale Petraeus, al comando delle forze in Iraq nel 2005, era fortemente convinto che “la conoscenza del terreno culturale può essere altrettanto importante, o in alcuni casi più importante, della conoscenza del terreno geografico”. Se le persone sono il “terreno” decisivo delle operazioni, allora tale terreno deve essere studiato e conosciuto con la stessa sistematicità con cui si studia il terreno geografico. A tale scopo l’approccio delle scienze sociali è più appropriato rispetto a quello delle scienze fisiche che tradizionalmente accompagnano la formazione dei militari, i quali devono affrontare anche compiti diversi rispetto alle normali attività a prevalenza cinetica a cui sono addestrati. Alle competenze tradizionalmente militari vanno dunque affiancate quelle linguistiche, di comunicazione interculturale e della mappatura del terreno umano con metodi interdisciplinari, attraverso il reclutamento, l’addestramento e l’impiego di Human Terrain Teams (HTT), ossia “Squadre (sul) terreno umano”, composte da scienziati sociali, civili e militari, con formazione adeguata pregressa, da schierare in operazioni sin dalla fase di pianificazione.
In Iraq e in Afghanistan queste squadre hanno generalmente dato risultati validi, soprattutto nel fornire un supporto “non combattente” e oggettivo ai comandanti in teatro. Nel periodo 2005-15 Il lavoro degli HTT ha permesso di incrementare la capacità militare di comprendere la cultura locale – e dunque riducendo incomprensioni e malintesi tra le forze d’intervento e la popolazione autoctona – a supporto del processo decisionale dei comandanti. Di tali capacità si sono avvalse anche le unità italiane in Afghanistan che hanno ricevuto il supporto di alcuni HTT statunitensi. Sulla base di queste esperienze è possibile affermare che l’HTS fornisce delle risposte ad alcune delle sfide poste dai conflitti ibridi. Ma, trattandosi di uno strumento, deve essere diretto e indirizzato da appropriate direttive del comandante che ne dispone: ciò postula cambiamenti organizzativi nella formazione del personale e nelle strutture preposte al consolidamento e alla fusione dei dati informativi, ancora focalizzate sul “nemico”. In particolare, alcune conoscenze di base di antropologia sociale e culturale sono essenziali per consentire ai comandanti, a ogni livello, di comprendere le peculiarità del terreno umano in cui si sviluppano le loro operazioni, di indirizzare la ricerca degli analisti di cui dispongono e di individuare le implicazioni sociali delle loro decisioni.
Negli Stati Uniti il programma è stato sospeso nel 2016, soprattutto a causa di pratiche contrattuali inefficienti nell’assunzione degli specialisti, molti dei quali contractors di etica e capacità professionale discutibili. Ciò non deve fuorviare: non è in discussione la validità del concetto, ma è fatale che, in tempi di tagli al bilancio, gli elementi non-cinetici siano i primi a cadere. Ciononostante, l’Esercito Italiano ha recepito l’esigenza di integrare queste specifiche capacità conoscitive negli assetti militari destinati ad operare all’estero, con l’obiettivo di accrescere la comprensione socio-culturale del terreno umano quale fattore di successo nelle operazioni non (o poco)-cinetiche in cui è impegnato. Il Centro Studi sulle Operazioni Post-Conflittuali di Torino sta sviluppando delle proposte di pacchetti formativi che, una volta approvati, potranno essere erogati a beneficio di comandanti e staff designati per impieghi “fuori area”. È ferma opinione di chi scrive che le Forze Armate abbiano bisogno di antropologi, sociologi ed esperti d’area (reperibili attraverso la Riserva Selezionata), e che gli ufficiali abbiano bisogno di maggiori conoscenze socio-antropologiche, anche al costo di sacrificare qualche nozione di analisi matematica. Non solo perché, come ebbe a dire un collega statunitense[i] “[Human Terrain Teams] went in there and figured out the tribal rivalries, and they figured out what needed to happen psychologically and culturally – they figured out who needed what in order for there to be peace”, ma anche per evitare nuove partenze a freddo quando arriverà il momento di un nuovo impegno in terre lontane, con culture e costumi poco conosciuti.
[i] Col. Drinkwater, CO TF FURY (4th/82nd), conversazione con l’Autore, 2010.
PER SAPERNE DI PIÙ:NATO HUMINT Center of Excellence (2014), Human aspects in NATO military operations. Disponibile su: www.natohcoe.org/download/1184/
Galli, C. (2013), “L’antropologia nella pianificazione delle operazioni militari”, Informazioni della Difesa, 5/2013. Disponibile su: www.difesa.it/InformazioniDellaDifesa/ periodico/periodico_2013/Documents/ R5_2013/28_37_R5_2013.pdf
McFate, M. (2005), “The Military Utility of Understanding Adversary Culture”, Joint Force Quarterly, 38. Disponibile su: www.sscnet. ucla.edu/polisci/faculty/chwe/austen/mcfate.pdf
Gli autori che pubblicano su questa rivista accettano le seguenti condizioni:
- Gli autori mantengono i diritti sulla loro opera e cedono alla rivista il diritto di prima pubblicazione dell'opera, contemporaneamente licenziata sotto una Licenza Creative Commons - Attribuzione che permette ad altri di condividere l'opera indicando la paternità intellettuale e la prima pubblicazione su questa rivista;
- Gli autori possono aderire ad altri accordi di licenza non esclusiva per la distribuzione della versione dell'opera pubblicata (es. depositarla in un archivio istituzionale o pubblicarla in una monografia), a patto di indicare che la prima pubblicazione è avvenuta su questa rivista;
- Gli autori possono diffondere la loro opera online (es. in repository istituzionali o nel loro sito web) prima e durante il processo di submission, poichè può portare a scambi produttivi e aumentare le citazioni dell'opera pubblicata (Vedi The Effect of Open Access).