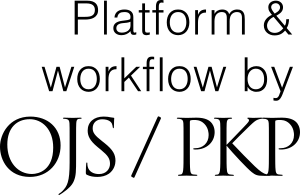Il paradosso della legalità: l’iper-normativismo come fattore di erosione del potere dello stato
Abstract
È ormai ampiamente consolidata, nel dibattito pubblico, l’idea che il progredire dei processi di globalizzazione abbia concorso a erodere il potere dello stato. In particolare dopo il crollo del Muro di Berlino, nel 1989, si è assistito a una vera e propria riscalarizzazione delle configurazioni socio-spaziali prodotte dallo sviluppo capitalistico, destinata a riverberare nel consolidamento di geografie politiche sempre più polimorfiche, in cui la territorialità non si concentra più attorno a un singolo predominante centro di gravità, ma tende a redistribuirsi tra molti livelli istituzionali sub- e sovra-statali (comuni e regioni, da un lato; organizzazioni macroregionali e internazionali, dall’altro). Lo stato, in altri termini, non è più il centro dell’universo politico.
Una delle conseguenze di questa nuova geografia generata dai processi di accumulazione del capitale – destinata oltre tutto ad accrescere le diseguaglianze, tanto tra gli stati, quanto al loro interno – riguarda il diritto, ovvero quello che è stato definito, con un’espressione alquanto efficace, il sistema immunitario delle società umane. Oggi, infatti, si assiste alla proliferazione di forme ibride giuridiche al di là dello stato (al di fuori, ma anche in “zone franche” al suo interno); a una crescente frammentazione del diritto che si concretizza, a sua volta, nelle forme sia di una dispersione territoriale dei poteri legislativi e giudiziari, sia di una crescita incontrollata dei settori di intervento normativo.
Da un lato, si assiste a uno sviluppo senza precedenti del diritto pubblico a opera delle organizzazioni internazionali, che si affianca a quello prodotto dai singoli stati e invade un numero crescente di aree (a volte coinvolgenti saperi ad alto contenuto tecnologico); dall’altro, anche gli attori privati, interni e internazionali, generano norme in maniera incessante, per regolare le attività tra di essi, ma anche con le agenzie pubbliche. Nel mondo globalizzato, in sostanza, non è più soltanto la politica a selezionare ciò che è giuridicamente possibile.
Il paradosso consiste nel fatto che proprio questo iper-normativismo rischia di segnare la definitiva rottura del patto storico che era stato raggiunto tra stato e diritto a compimento di un processo plurisecolare di state-making; con la conseguenza di mettere in pericolo la funzionalità dello stato, soprattutto per quanto riguarda il suo reale potere di sanzione.
Il dibattito su questi temi è estremamente articolato e non privo di opinioni contrastanti. Ciò su cui i più convengono, tuttavia, è che si stia assistendo a una crescente erosione della statualità destinata a metterne in discussione i due confini istitutivi: interno-esterno e pubblico-privato. Per quanto riguarda il primo confine, esso viene superato nelle relazioni tra il singolo stato e le organizzazioni internazionali (si pensi al principio di sussidiarietà sancito dal Trattato di Maastricht del 1992; o al diritto di intervento umanitario); e messo ancor più in discussione dal fatto che lo stato come entità giuridica non può più essere in grado di rispondere alle esigenze normative e di risoluzione delle dispute quando l’economia, la criminalità o l’inquinamento ignorano i confini nazionali.
Per quanto riguarda il secondo confine, pubblico-privato, il problema maggiore riguarda la proliferazione senza precedenti del corpo di diritto positivo che governa le relazioni tra privati, si tratti di semplici individui o di persone giuridiche quali le corporations. Il post-1989, in sostanza, non soltanto non rallenta il processo storico di positivizzazione del diritto; al contrario, lo accelera oltre misura, generando nuove fattispecie che mettono a repentaglio l’ordine tradizionale dell’universo legale: degli ibridi giuridici che l’apparato concettuale tradizionale creato dallo stato non è nemmeno in grado di comprendere e ingabbiare entro una specifica categoria.
Il problema non si esaurisce nella comprensione (e nella gestione) di questa vera e propria babele giuridica. Occorre ancora chiedersi, riprendendo il tema della sanzione, che conseguenze abbia tutto ciò sul “potere di punire”, ovvero sulla sfera dell’esercizio della forza fisica. Se nel mondo globalizzato non è più il solo a selezionare ciò che è giuridicamente possibile, tuttavia lo stato dovrebbe poter mantenere quanto meno la prerogativa di determinare ciò che è giuridicamente vietato, perché costituisce un’offesa contro la collettività.

Complexo do Alemão. Rio de Janeiro, Brasile. (Fonte: Flickrs/Saulo Cruz)
L’erosione del potere dello stato, invece, mette sempre più a rischio la regolarità stessa dell’azione penale; al punto da prefigurare la proliferazione anche di “stati d’eccezione” nella duplice forma dell’emanazione di norme di emergenza e di spazi territoriali sottratti all’effettivo controllo del potere statale. La dichiarazione di una “guerra globale al terrorismo”, ad esempio, ha giustificato, nel mondo post-1989, la trasformazione di misure eccezionali e provvisorie in pratica ordinaria e dominante di governo; fatto questo che rischia di alterare in maniera radicale le tradizionali forme costituzionali, rendendo sempre più indeterminato il confine tra democrazia e assolutismo (basti pensare al Patriot Act approvato dal Congresso degli Stati Uniti il 26 ottobre del 2001, all’indomani degli attentati dell’11 settembre, e rinnovato fino al 2019 nonostante le polemiche da esso suscitate).
D’altra parte, il moltiplicarsi di attori non-statali della violenza che competono con maggiore o minor successo per il controllo di porzioni del territorio statale (e, a volte, all’interno di uno stesso contesto urbano) fa venir meno la condizione di pace garantita dallo stato e causa piuttosto il generarsi di veri e propri cluster di sovranità. Così facendo, si ripropone nei fatti il ritorno a forme irregolari e in competizione tra loro di “amministrazione della giustizia” – seppure non nella forma che aveva caratterizzato l’epoca premoderna, ma secondo modalità nuove e decisamente market-oriented.
Nella società globalizzata, infatti, l’economia del potere di punire vede affiancarsi ai tradizionali attori pubblici (apparati giudiziari e forze di polizia) un crescente numero di marchi privati sia legali (le diverse imprese che operano nel settore della sicurezza) sia illegali (dagli squadroni della morte, ai vigilanti, alle mafie e alle gang). Entrambi i generi di marchi privati operano con finalità di profitto, nella forma del pagamento di servizi o dell’estorsione, rinunciando quindi a qualunque pretesa di universalità ed equità. Quelli criminali, in più, a volte rivendicano a tutti gli effetti il titolo di gruppi politici, il cui rispettivo grado di legittimità si gioca sulla capacità o meno di ottenere obbedienza da parte di chi è soggetto al loro dominio.

Membri del gruppo di autodifesa della Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). (Fonte: Flickr/Conecta Abogados)
Nella realtà quotidiana di un numero crescente di paesi, infine, la distanza che dovrebbe separare l’azione pubblica da quella privata in relazione all’accertamento della colpa e all’esecuzione della pena tende ad assottigliarsi, fin quasi a scomparire, nel momento in cui tra i corpi dello stato si diffonde la pratica delle esecuzioni extragiudiziali, mentre i gruppi criminali riscoprono la faida come normazione della vendetta. Le prime – l’uccisione sommaria di individui, al di fuori di qualunque procedimento penale – sono ormai una pratica corrente, non solo in tempo di guerra e non solo a opera di regimi autoritari (basterebbero i frequenti rapporti delle organizzazioni umanitarie a darne conto). La faida, invece, viene riscoperta da un numero crescente di attori non-statali della violenza come ulteriore meccanismo di autoregolazione all’interno di un più ampio processo di clanizzazione dell’intera società. E non si tratta, sia chiaro, di un semplice arcaismo, residuale di aree di sottosviluppo o rivalutato in regioni abbandonate dallo stato. La faida, infatti, non consiste in un’inflizione arbitraria o anarchica di sanzioni tra individui, ma rivendica con successo (a volte anche nella complessità delle regole e nell’astrusità del linguaggio) la pretesa di emulare il diritto penale statale – si pensi, per fare due esempi storici, al Codice barbaricino in Sardegna o al Kanun in Albania.

Studenti filippini protestano contro le esecuzioni extragiudiziali. (Fonte: Aaron Favila)
In un simile contesto, due categorie di attori sono destinate nel tempo ad acquisire un vantaggio competitivo; e non solo nei confronti dei criminali comuni, ma anche dello stato che dovrebbe combatterle: i potenti e i mafiosi. I primi, i responsabili dei cosiddetti white-collar crime, possono contare su fattori quali: 1) la capacità di influenzare la definizione stessa del reato, attraverso l’accesso diretto o la contiguità con il sistema politico; 2) la possibilità di dissimulare la natura criminale delle proprie attività giocando sulla maggiore ambiguità dei reati commessi (l’evasione fiscale, la corruzione, il riciclaggio di denaro) rispetto ai normali crimini di strada; 3) la funzionalità dei propri reati alla sopravvivenza e all’ampliamento delle zone grigie che vengono a generarsi con i sistemi politico ed economico – basti pensare ai fenomeni di corruzione o di voto di scambio; o al mercato dei beni illeciti o contraffatti; 4) la capacità di aggregare attorno ai propri crimini professionalità tra le più diverse – manager di grandi aziende, avvocati e commercialisti, broker finanziari, esperti di comunicazione, ecc. – e interessi tali da arrivare a produrre economie di scala e vantaggi sistemici.
I mafiosi, da parte loro, possono contare su due ulteriori vantaggi: 1) la superiore capacità di differenziare i propri crimini, in settori diversi del mercato sia dei beni sia dei servizi illeciti; 2) la possibilità di “internalizzare” il costo della protezione dei propri membri e dei propri traffici. I mafiosi, disponendo di armi e di soldati e non avendo scrupoli a farne uso, sono in grado di servirsene per proteggere i propri interessi e anche quelli dei propri partner criminali del mondo lecito; ma qualora tra di essi dovessero sorgere dei conflitti, saranno i secondi a soccombere, non potendo nemmeno aspirare alla protezione dello stato.
Per saperne di più
Armao, F. (2016), “Back to the clan: Organized crime as state surrogate for the market”, in Ruzza, S., Jakobi A. P. e Geisler, C. (ed.) Non-State Challenges in a Re-Ordered World. The Jackals of Westphalia, Routledge.
Brenner, N. (2004) New State Spaces: Urban Governance and the Rescaling of Statehood, Oxford University Press.
Luhmann, N. (2004) Law as a Social System, Oxford University Press.
Ruggiero, V. (2015) Perché i potenti delinquono, Feltrinelli.
—
Published in:Gli autori che pubblicano su questa rivista accettano le seguenti condizioni:
- Gli autori mantengono i diritti sulla loro opera e cedono alla rivista il diritto di prima pubblicazione dell'opera, contemporaneamente licenziata sotto una Licenza Creative Commons - Attribuzione che permette ad altri di condividere l'opera indicando la paternità intellettuale e la prima pubblicazione su questa rivista;
- Gli autori possono aderire ad altri accordi di licenza non esclusiva per la distribuzione della versione dell'opera pubblicata (es. depositarla in un archivio istituzionale o pubblicarla in una monografia), a patto di indicare che la prima pubblicazione è avvenuta su questa rivista;
- Gli autori possono diffondere la loro opera online (es. in repository istituzionali o nel loro sito web) prima e durante il processo di submission, poichè può portare a scambi produttivi e aumentare le citazioni dell'opera pubblicata (Vedi The Effect of Open Access).