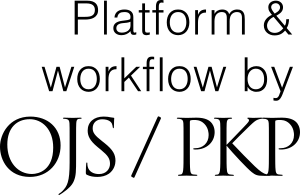Il peacebuilding italiano tra idee, pratica e percezioni. Riflessioni a partire da una conversazione con Francesco Talò, Rappresentante Permanente italiano presso la NATO a Bruxelles
Abstract
Per cercare di delineare i contorni del peacebuilding italiano non si può che partire da una riflessione più ampia su cosa si intenda con il termine “peacebuilding”. A livello internazionale esso è stato spesso definito come una sorta di terza fase della “catena della sicurezza” che va dalla prevenzione del conflitto, alla gestione del conflitto – tramite operazioni di peacekeeping o peace enforcement a seconda dell’applicazione in termini onusiani del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite – per poi giungere a una situazione post-conflittuale dove, teoricamente, troverebbero spazio tutta una serie di attività volte alla (ri)costruzione della pace che vanno sotto il nome di “peacebuilding”. La realtà è molto più complessa, con fasi che precedono un conflitto o una guerra già caratterizzate da violenza diffusa e fasi tecnicamente “post-conflitto” che non sono poi sempre così pacifiche, come dimostrato in tempi recenti dal caso esemplare dell’Afghanistan. Diventa quindi molto difficile isolare le attività di costruzione e sostegno alla pace, formalmente riconosciute come “peacebuilding”, da quelle di diplomazia, cooperazione allo sviluppo o mantenimento della sicurezza in senso più tradizionale.
Questa fluidità pone dunque in evidenza il ruolo di percezioni e punti di vista nel valutare l’impegno di un paese piuttosto che di un altro a supporto del peacebuilding, inteso come supporto alla pace in senso lato. Il termine “peacebuilding”, ad esempio, è raramente associato a contesti tradizionalmente più securitari come quello della NATO o delle attività delle Forze Armate, le cui attività non vengono quindi percepite, né tanto meno “contabilizzate”, in quel contesto. Guardando al ruolo italiano ciò è penalizzante perché in questo ambito l’Italia fa più di quanto venga percepito.
Oltre alle azioni da parte delle organizzazioni non governative (ONG) e della Cooperazione allo Sviluppo, ci sono iniziative degne di nota anche da parte delle Forze Armate, tanto che si parla di una “cultura italiana” nell’ambito delle operazioni di mantenimento della pace. Sono infatti riconosciute anche a livello internazionale le caratteristiche e specificità del “modo di fare” italiano che pone i nostri contingenti molto più a contatto con le realtà locali, molto più predisposti alla mediazione con la società civile e alla collaborazione con altri attori più comunemente associati alle dimensioni di pace e sviluppo: un esempio storico, molto considerato e studiato, è quello del Mozambico in cui l’Italia ha avuto un ruolo di primo piano grazie all’azione di una ONG come la Comunità di Sant’Egidio – poi sfociata in un accordi di pace più formale – e all’iniziativa di pace su mandato delle Nazioni Unite con un contingente a guida italiana. E questo, in fondo, rientra di fatto e a pieno diritto nell’ambito del peacebuilding.
Continuando la riflessione iniziale, per valutare il ruolo e l’impatto del peacebuilding italiano è opportuno soffermarsi sul tema della sicurezza umana. In fin dei conti lo scopo delle attività di costruzione e sostegno della pace è quello di permettere alle persone e alle società di vivere in una situazione di sicurezza a tutto tondo, non solo prima e durante un conflitto, ma anche dopo, per evitare che il conflitto si possa innescare nuovamente – in questo senso fare peacebuilding vuol dire allo stesso tempo fare prevenzione dei conflitti. Da questo punto di vista il ruolo italiano ha delle peculiarità intrinseche, anche nel contesto militare e vale la pena citarne due che fanno entrambe capo ai nostri Carabinieri.
Nonostante alcuni – pochi – paesi abbiano forze di gendarmeria in un certo senso simili, i Carabinieri sono una realtà, articolata e ben radicata, che sostanzialmente esiste solo in Italia e che rappresenta un’eccellenza nell’ambito della polizia di stabilità. Questo ruolo di punta si collega a un’altra questione importante che è quella, diciamo, del “vincere la pace”. Abbiamo visto come le grandi potenze siano in grado di vincere delle guerre guerreggiate, come in Iraq, per poi ritrovarsi, il giorno dopo, con una pace che sfugge di mano a militari che fino a poco prima combattevano contro il nemico e che sono magari meno attrezzati per mantenere il controllo di una città ancora instabile, dove sono ancora presenti attori armati, dove la violenza è ancora persistente e non si può dire ci sia veramente la pace. In queste circostanze si tratta quindi di costruire la pace, di fare peacebuilding. E questo è un po’ nel carattere dei Carabinieri che sono sì una forza armata, ma rappresentano anche una forza di polizia abituata ad agire in contesti urbani e ad avere criteri di ingaggio non solo nei confronti di altre forze di pari livello, capacità e caratteristiche, ma anche a trattare con i civili nel loro quotidiano, formando quel continuum che va dal singolo cittadino alle istituzioni – aspetto, anche questo, fondamentale per la costruzione e il sostegno della pace.
Un altro tema che sicuramente può rientrare nel contesto della sicurezza umana – e quindi del peacebuilding – è quello della tutela del patrimonio culturale e anche in questo caso la tradizione dei Carabinieri è ormai lunghissima. Questo tipo di impegno è importante e va riconosciuto come tale poiché si collega alla prevenzione di eventi drammatici in cui alcuni attori in conflitto cercano di annientare l’identità dell’avversario distruggendone il patrimonio culturale: l’abbiamo visto quanto i Talebani ordinarono la distruzione dei Buddha di Bamiyan, poi l’abbiamo visto più violentemente e da vicino nelle varie offensive di Daesh in Iraq e Siria, ma l’avevamo già visto ai tempi dei Nazisti. In questo ambito, l’Italia ha delle capacità uniche: ci siamo impegnati nella preservazione e tutela del patrimonio culturale in Afghanistan e in Iraq e lo stiamo facendo tutt’ora in Kosovo dove i Carabinieri proteggono ancora i monasteri serbi. Allo stesso tempo e sempre in ambito artistico-culturale, i Carabineri sono anche impegnati in azioni di contrasto al traffico di opere d’arte e beni culturali e questa grande esperienza italiana potrebbe rientrare con facilità sotto l’etichetta “peacebuilding” in quanto i traffici illegali di questo tipo sono tra le principali fonti finanziarie che alimentano i conflitti in tutto il mondo.
Possiamo poi aggiungere il tema della salute, che insieme a quello della tutela ambientale e del contrasto al cambiamento climatico, rappresenta l’enorme sfida del nostro tempo, tanto nei confronti della sicurezza umana quanto della sicurezza in generale – in Italia e nel mondo. È ormai riconosciuto che le crisi sanitarie e, ancora più pesantemente, quelle ambientali, possono essere dei moltiplicatori di rischio in termini di destabilizzazione e insicurezza: forse non direttamente – anche se ciò non è certo da escludere – tali crisi possono esacerbare conflitti esistenti o generarne di nuovi. Impegnarsi quindi per la salute e la tutela dell’ambiente possono quindi essere considerate attività di costruzione e sostegno della pace o prevenzione del conflitto. Per esempio, in Afghanistan e Kosovo, dove l’impegno del nostro paese è più evidente, il contingente italiano è oggi impegnato ad assistere la popolazione locale nella lotta contro il COVID-19. Così facendo, l’Italia sta contribuendo al rafforzamento della stabilità di quelle società e, quindi, sta attivamente sostenendo la pace o “facendo” peacebuilding, inteso come rafforzamento della resilienza sociale che, nel caso italiano, parte ancora una volta dalla nostra stessa esperienza per poi essere messa a disposizione di partner o delle società nei paesi in cui si va ad operare.
A fronte delle esperienze menzionate fin qui, è utile sottolineare un aspetto problematico del ruolo e dell’impatto, reali e percepiti, del peacebuilding italiano: la sua forza, ma anche una debolezza, sta nel fatto che esso si basa in larga parte su esperienze sul terreno, che nascono sul suolo italiano e si sviluppano in missioni all’estero. Altri paesi, percepiti come più attivi o protagonisti nel panorama internazionale, partono da una base teorica che poi viene applicata sul terreno. In Italia è successo il contrario. Insomma, il “peacebuilding italiano” potrebbe non essere limitato alle tradizionali attività classificate sotto tale etichetta.
Riflettere su questi temi e sforzarsi, come si sta facendo, per concettualizzare e valorizzare l’idea e la pratica del peacebuilding italiano potrebbe quindi allargarne i contorni e contribuire a migliorare la percezione – e soprattutto l’auto-percezione – del ruolo e dell’impatto dell’Italia nelle attività di costruzione e sostegno della pace. In questo senso, una maggior consapevolezza dell’impegno italiano ci aiuterebbe a capire cosa non facciamo abbastanza, spingendoci a fare di più, ma anche a riflettere su quello che invece facciamo, quasi senza accorgercene o percepirlo, aumentando l’autostima e la volontà di fare di più e meglio, anche allargando il cerchio ad altri contesti e ambiti dove l’Italia è meno presente o protagonista.
Published in:Gli autori che pubblicano su questa rivista accettano le seguenti condizioni:
- Gli autori mantengono i diritti sulla loro opera e cedono alla rivista il diritto di prima pubblicazione dell'opera, contemporaneamente licenziata sotto una Licenza Creative Commons - Attribuzione che permette ad altri di condividere l'opera indicando la paternità intellettuale e la prima pubblicazione su questa rivista;
- Gli autori possono aderire ad altri accordi di licenza non esclusiva per la distribuzione della versione dell'opera pubblicata (es. depositarla in un archivio istituzionale o pubblicarla in una monografia), a patto di indicare che la prima pubblicazione è avvenuta su questa rivista;
- Gli autori possono diffondere la loro opera online (es. in repository istituzionali o nel loro sito web) prima e durante il processo di submission, poichè può portare a scambi produttivi e aumentare le citazioni dell'opera pubblicata (Vedi The Effect of Open Access).